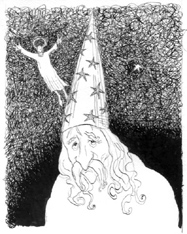LA MAGIA E SAN BARBATO
L'opera di evangelizzazione di questo santo, che fu vescovo di Benevento, è legata alla conversione al Cristianesimo delle "terribili genti longobarde", che erano arrivate a conquistare il Sannio nel VI secolo d.C.. I Longobardi elessero Benevento a capitale del loro ducato e nel territorio sannita, che avevano conquistato, per lunghi anni restarono fedeli ai loro culti pagani, venerando il simulacro di una vipera e un albero sacro. L'opera di San Barbato è illuminante nella storia piuttosto lacunosa della chiesa meridionale del VI secolo, travolta dagli avvenimenti della guerra greco-gotica e quindi dall'invasione dei Longobardi, che nel 580 avevano distrutto anche il monastero di Montecassino. Con San Barbato la chiesa riemerge dal periodo di "clandestinità" in cui l'avevano relegata gli avversi avvenimenti storici. In un convegno svoltosi a Castelvenere il 27 febbraio 1999, dedicato a San Barbato, il relatore prof. Carmelo Lepore, nel suo intervento, ha così riassunto l'azione pastorale di Barbato, individuandone tre momenti successivi:
La grande ricompensa per l'opera di intercessione di Barbato fu l'elezione a vescovo e l'estensione della giurisdizione ecclesiastica della chiesa di Benevento sull'importantissimo santuario di San Michele sul Gargano oltre che sulla Chiesa di Siponto, distrutti dall'imperatore Costante, prima dell'assedio di Benevento. Adolfo De Blasio così descrive la conversione di Romoaldo, duca longobardo di Benevento: "Molta parte spiegò S. Barbato per la conversione e il buon governo del Duca Romoaldo. L'occasione fu l'assedio posto a Benevento dall'Imperatore Costante, venuto in Italia da Costantinopoli per rivendicare le terre tolte ai Goti da Belisario e da Narsete, con tanto spargimento di sangue. Sbarcato a Taranto, espugnò Acerenza, sottomise Lucera, retrocesse a Siponto del quale si impossessò radendolo al suolo e coinvolgendo nelle sue rovine il Santuario di S. Michele, al Gargano; piombò su Benevento, cinse la città di rigoroso assedio, così da non farvi entrare né foraggio né alcuna vettovaglia. I giorni passavano; l'aiuto sperato dal padre Grimoaldo, re d'Italia, non arrivava; il popolo sentiva il disagio e la fame. In mezzo a così certo imminente pericolo, ecco l'apostolo S. Barbato. Con parole infuocate, esorta il popolo a convertirsi e ad avere fiducia nell'aiuto della Madonna. Egli prega, ha una visione. Conduce Romoaldo alle mura di cinta della città, dove anche il duca vede la Madre di Dio tutta smagliante di luce, terribile come oste schierata in campo contro il nemico. Il greco imperatore, che da un momento all'altro aspettava impaziente la resa della città e già sognava un immenso bottino, considerando che l'esercito, già in marcia, di Grimoaldo gli avrebbe preclusa la ritirata verso Napoli, sciolse l'assedio, portando seco solo la sorella del duca. Ma iuxta fluenta Caloris, nei pressi della terra natia di S. Barbato, oggi Castelvenere, l'esercito greco ebbe la peggio, e potè appena salvarsi ritirandosi a Napoli. S. Barbato, ancora semplice sacerdote, ottenendo da Dio la liberazione di Benevento, risparmiò tanti dolori alle popolazioni della valle telesina". A questo santo alcuni vogliono collegare anche la leggenda delle streghe di Benevento. In un saggio miscellaneo a cura dello storico Francesco Romano, "Benevento tra mito e realtà", si legge: "A Benevento…lo hanno scritto tanti…le streghe erano di casa. La leggenda popolare è intimamente legata per le sue origini ad un rito praticato, intorno agli anni 670 e 690, dai Longobardi dopo l'occupazione della città. In quegli anni i Longobardi per loro consuetudine solevano riunirsi attorno ad un "albero sacro" a Wothan, in un posto coltivato a noci non lontano da Benevento. Appendevano ai rami dell'albero delle pelli di pecora (coria) e, correndo a cavallo con le spalle voltate, cercavano con la lancia di strapparne qualche pezzo, che rappresentava un presagio fausto ed assicurava la protezione degli spiriti… Anche tra leggenda e storia resta sospeso lo stesso racconto dell'impresa di questo santo, che in quegli anni fu Vescovo di Benevento: Secondo Barbato appunto il culto dei Longobardi per le streghe si sarebbe sviluppato "all'immagine di una vipera" e dell' "albero sacro". Al governo del nuovo Ducato Meridionale dei Longobardi c'era allora il duca Romoaldo il quale, nel corso dell'assedio della città ad opera dell'imperatore bizantino Costantino, detto pure Costanzo II, richiese la protezione di S. Barbato, promettendo in cambio di rinunziare all'idolatria".